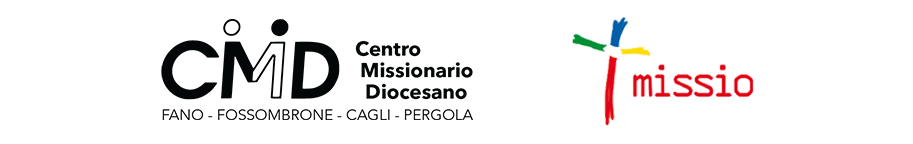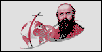La trentunesima “lettera dalla missione” è quella che scrive Sara raccontando la sua recente esperienza in Kenya, nella missione di Kipsing. Godetevela!
”(Ulisse) quando fu di nuovo a casa capì, con stupore, che la sua vita, l’essenza stessa della sua vita, il suo centro, il suo tesoro, si trovava fuori da Itaca, in quei vent’anni di vagabondaggio. E quel tesoro l’aveva perduto, e l’avrebbe recuperato solo raccontando.” [Kundera – L’ignoranza]
Comincio con questa frase di Kundera la mia breve e maldestra testimonianza del viaggio in Africa, in Kenya. Queste poche parole riferite dell’avventuriero per eccezione mi hanno smosso qualcosa dentro, mi ci sono ritrovata, rendono alla perfezione cosa significhi il Mal d’Africa che, fin da poco prima del ritorno a casa, mi accompagna come un’ombra e, di tanto in tanto, quando abbasso la guardia o vedo qualcosa che non mi piace, mi atterra con immagini prepotenti e cariche di una forte nostalgia. Mi chiamo Sara, sono una studentessa universitaria, ho compiuto ventidue anni il 4 gennaio, esattamente quattro giorni prima di partire per la mia esperienza nella missione di Kipsing in Kenya; tenterò di rendere giustizia alla grande ricchezza che mi sono riportata a casa il 30 gennaio di quest’anno.
Voler visitare una missione non era un desiderio dell’età adulta, un’occasione apparsa dal nulla e presa al volo; sin da bambina ho desiderato intraprendere questo viaggio, vivere un’esperienza così, conoscere una realtà diversa dalla mia. Deriva tutto dalla mia educazione e dalle persone che ho frequentato sin da piccola, è stato loro il merito se questo sogno ha fatto parte di me sin dalla tenera età e ora si è realizzato.
Dagli otto ai ventuno anni ho pazientemente aspettato, prima di essere abbastanza grande, poi che la vita mi presentasse l’occasione, ma alla fine capii che l’occasione dovevo trovarla io stessa.
Fu così che conobbi Don Luciano e in seguito le altre sei persone che mi hanno accompagnato laggiù (Filippo, Carla, Laura, Silvia, Sauro e Marta), riuscii a coinvolgere anche mia zia (Daniela) e la compagnia fu al completo.
Siamo partiti l’8 gennaio da Fano e siamo arrivati a Nairobi alle quattro del mattino del 9. Personalmente ho vissuto i mesi prima di partire investita da paure e da ansie che comprendevano, a intervalli regolari, ragni somali, ebola, cambiamenti e aspettative deluse. Paure e ansie che sono sparite nel momento stesso in cui sono arrivata in Africa, tanta era la gioia di esserci dopo aver a lungo sognato quel continente, così forte la sensazione di trovarmi al sicuro e a casa, che ogni cosa che avevo temuto mi è apparsa così piccola. A Kipsing siamo arrivati di sera, almeno una parte di noi, e solo il giorno dopo abbiamo visto chiaramente il paesaggio che ci avrebbe abbracciato per le tre settimane successive.
C’è tanta bellezza laggiù e si ha occasione di capire tanto anche in poco tempo. Personalmente non ho fatto molta fatica ad ambientarmi, a prendere il ritmo, perché era molto vicino alla mia indole tranquilla e riflessiva (e credo che sia anche questo che mi abbia reso traumatica la fine del viaggio), ma credo anche che tutti si sentano un po’ tra muri “familiari” quando stanno lì. Padre James e il diacono Josephat hanno contribuito a far sì che non ci sentissimo estranei, coinvolgendoci completamente nella vita quotidiana e integrandola con ciò che ci portavamo dall’Italia. 
Durante il nostro soggiorno visitammo Marsabit, rimanendoci tre giorni, ospitati dalle Pink Sister, il paesaggio era così diverso da quello che avevamo abitato per i primi cinque giorni, quel paesaggio che chiamavamo già “casa”. Vedemmo la realtà dei bambini ricoverati nella casa che gestiscono, bambini con handicap che non si vergognavano di essere nati così, ragazzi impavidi, gioiosi, fieri di essere ciò che sono. Giocammo a calcio con loro, ascoltammo i loro racconti, li esaudimmo quando chiedevano di farsi le foto con noi. I sorrisi di tutti loro, ognuno con la sua particolarità, si stamparono con inchiostro indelebile nei nostri cuori.
Nel viaggio di ritorno da Marsabit facemmo una deviazione per Wamba, dove c’è l’ospedale fondato da un italiano, e anche lì vi erano le Pink Sister che gestivano un’altra casa per bambini e ragazzi portatori di handicap; fu uscendo da quel ricovero che mi sentii un po’ oppressa per la prima volta, un po’ ingiustamente fortunata. Tenni in braccio per tutta la visita il bambino più piccolo, soffre di cecità sin dalla nascita, e quando lo vidi per la prima volta, piangeva. Ma quando lo presi in braccio il suo pianto si trasformò in risa, le sue mani trovarono la mia collana e cominciarono a giocarci. Separarsi da quel piccolo angelo fu difficile, terribilmente difficile, avrei voluto portarlo con me e prendermi cura di lui per tutta la vita, ma dovetti salutarlo per sempre, ciò mi spezzò il cuore.
I giorni che passammo a Kipsing furono molto diversi da quelli della nostra piccola gita al di fuori di lì. In quella che già sentivamo casa nostra avevamo stabilito tacitamente le nostre routine, i nostri ruoli, avevamo imparato a riconoscere i volti di coloro che bazzicavano nella missione quasi continuamente, portammo qualcosa di buono con i nostri lavori di manutenzione (pitturammo i dormitori e sistemammo, per quanto possibile, i bagni), riuscimmo anche a visitare i villaggi in cui padre James fa catechesi e a constatare se gli asili funzionino come dovrebbero. Siamo stati parte della comunità quando con le donne abbiamo preparato il chapati, quando facevamo giocare i bambini nei lunghi pomeriggi, quando ci svegliavamo presto per le messe o quando ballavamo in quelle delle dieci della domenica.
Ho imparato a lavorare e non sentire la fatica, ho re-imparato a stupirmi per il nuovo, a gustare con gli occhi quei colori vivaci che portavano addosso i samburu e a non scandalizzarmi se un uomo tentava di comprarmi per mille cammelli e qualche centinaia di mucche, ho imparato, vedendo il loro modo di vivere, che l’essenziale qualche volta ti ricorda di apprezzare anche quel superfluo che hai e non ti accorgi di avere, ma di cui non senti la mancanza in quei luoghi. Ho imparato ad accontentarmi di lavare a mano i vestiti e a non stirarli, ho imparato che quello che hai nel piatto deve essere mangiato perché fuori dalla porta, a poche centinaia di metri, c’è gente che fa un solo un pasto al giorno. La cosa più divertente che ho imparato è stata quella di non sentirmi in colpa durante le lunghe pause pomeridiane, quando il sole scottava e non potevi andare a zonzo nella savana, e ti ritrovavi a far nulla sotto la veranda; i tempi dilatati, il ritmo lento e pacifico ti abbracciavano e star con le mani in mano in quel luogo aveva cambiato accezione alla parola ozio: a casa la sentivi negativa, lì era in armonia, era quasi un segno che ti stavi integrando.
Ma sono i bambini coloro che mi hanno insegnato di più. Quei piccoli volti governati dall’entusiasmo, quegli occhi scuri che trasmettevano la gioia di vivere, quel primordiale istinto di esistere che in Italia spesso e volentieri non incontri, mi hanno lasciato dentro la sensazione di aver incontrato l’amore di Dio in ognuno di loro. Nelle loro risate, nella loro curiosità, nei loro tentativi di farsi capire, nel loro affidarsi alla stretta delle tue braccia anche se non ti conoscono, ho riconosciuto una bellezza autentica, unica, che mi ha reso migliore.
In quei ventuno giorni ho riscoperto il senso della vita, la fortuna di averne una.
Al momento di salutare Kipsing le lacrime non potevano far altro che scendere, mentre il Mal d’Africa , quello di cui sentivo parlare ma che ancora non conoscevo, si appropriava del cuore e lo rapiva per sempre; ora lo tiene appiccicato a quella terra calda e rossa, a quelle mani scure che mi hanno cercato fin dal primo momento, al cielo stellato che mi stupiva ogni sera, quando alzavo gli occhi per godermi la meraviglia del manto nero puntinato da milioni di lucciole bianche, e mi faceva sentire così piccola.
Agli sgoccioli dell’esperienza passammo anche qualche giorno nella missione di ‘Ngare Mara, gestita sempre dalle Pink Sister, visitammo la riserva naturale imbattendoci in animali che fino a quel momento avevamo visto esclusivamente in televisione. Ma anche trovarsi faccia a faccia con sei leonesse, un centinaio di elefanti, qualche giraffa, facoceri, antilopi e quant’altro, non riuscì a distrarmi dalla consapevolezza che stava già finendo tutto; si sentiva l’aria dell’Italia che ci richiamava indietro e non riuscii a tenere nascosta la tristezza che mi governava, ero quasi in lutto. Mentre in quei giorni alla missione di Kipsing mi ero inconsciamente rifiutata di tenere i tempi, di segnarmi date o appuntarmi ciò che vedevo o facevo, fare un passo verso Nairobi mi scosse, salutare James mi distrusse, e cominciai a scrivere. Io, che amo tanto raccontare attraverso la scrittura, sorprendentemente non ero riuscita ad applicarmi nei giorni precedenti, probabilmente fu il desiderio di restare a far muovere la penna sulla carta, forse per tentare, anche solo con le parole, di trattenermi laggiù più a lungo di quello che mi era concesso.
Nei ricordi che mi sono riportata in Italia sento ancora i canti della messa che traducevano i sentimenti del cuore, rivedo i balli del matrimonio Samburu a cui abbiamo partecipato, mi risuonano in testa gli aforismi di Tony o il particolare YES di Josephat quando parlava con noi. Nel petto ho l’impronta dell’orecchio di Toma, la sento che cerca il battito del mio cuore per addormentarsi, qualche volta pare che il collo si pieghi in modo strano come nei balli in cui ci coinvolgevano le donne dei villaggi, mi manca addirittura il ragliare notturno dell’asino che passeggiava nel cortile o quella zanzariera bucherellata che usavo per proteggermi da un’eventuale visita di aracnidi più che per proteggermi dalle zanzare, quando chiudo gli occhi mi viene così facile immaginare la pianura rossa battuta dal sole e abbracciata dalle montagne.
Riprendere il ritmo della mia vita è stato più complicato del previsto. Nei primi tempi, dopo il ritorno, mi svegliavo di notte e non riuscivo a capire dove fossi, sentivo estranea la camera in cui dormivo da una vita. Mi scoprivo delusa nel sapere che non ci sarebbe stata la messa delle sei e mezzo del mattino, detta in un linguaggio incomprensibile, che non ci fossero James e Josephat a salutarmi in inglese o i miei compagni di viaggio a sorridermi, che a colazione non avrei trovato BlueBand, pane fatto in casa, frutti della passione, mango e avocado, che alle dieci non mi sarei immersa nella savana armata di rullo e vernice e scrutata da occhi che trovavano incomprensibile quello che stavamo facendo, che non avrei dovuto lavare a mano i vestiti, che non avrei potuto lasciare che i capelli si asciugassero al sole, che alle magliette leggere avrei dovuto sostituire quelle di lana, che avrei guidato personalmente la macchina invece di saltare sul cassone del pick-up verde, schivare i rami carichi di spine o tentare di ammortizzare buche inevitabili. La mia vita mi era diventata estranea tutta a un tratto, come se ci fosse stato uno scambio, come se Vergineto non fosse il luogo che avevo abitato per ventidue anni
Ma c’è stata una cosa che hanno notato tutti al mio ritorno e che mi ha fatto sentire anche un po’ incompresa varcando la soglia di casa: il sorriso. Sono tornata felice, felicissima, da quelle tre settimane. L’entusiasmo mi scorreva nelle vene come sangue e ha collimato prepotentemente con la grigia realtà che mi preparavo a risentire mia, con le cose brutte che erano successe durante la mia assenza e che hanno messo un po’ in ombra quella mia voglia di raccontare, di gioire, di portare la mia esperienza a quelle persone che avevo lasciato a casa.
In Africa avevo provato un po’ di senso di colpa per non aver sentito la mancanza della “me italiana”, per non aver trovato la lontananza un peso, ma quasi una fortuna, per essermi abituata immediatamente a non vedere il volto dei miei cari ogni giorno, per considerare quasi superfluo raccontare per telefono di quello che vivevo. Ero convinta, sono convinta, che per comprendermi dovrebbero vivere questa esperienza, farsi contagiare dalla bellezza di quei luoghi e di quelle persone, da quando sono tornata continuo a consigliarla a tutti, a volere che la facciano.
Io ho affrontato e vinto paure, ho conosciuto gente stupefacente, sono riuscita ad accettare e comprendere la diversità in tutte le sue forme, sono cresciuta. E vorrei tornare! Ci sto già pensando…
Concludo il mio racconto con un ringraziamento moltiplicato per otto. Grazie a Don Luciano, Filippo, Marta e Sauro, Carla, Laura, Silvia e zia Dani, siete stati la mia famiglia e sono contenta di aver vissuto questa esperienza con voi. Grazie per questa opportunità, per questo sogno che si è realizzato, per questi ricordi che mi arricchiscono e per questa sana nostalgia che sento ogni giorno.
Sara